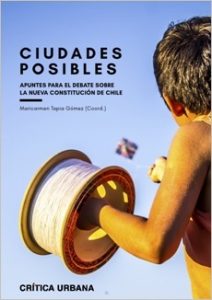Por Clara Zanardi |
CRÍTICA URBANA N.13![]()
|
|
“È nel momento culminante del Carnevale, mentre una squallida scenografia rituale precipita lo sciatore Kristian Ghedina dal campanile di Piazza San Marco tra le braccia del sindaco, che giunge la decisione di chiudere Venezia per prevenire la diffusione del Covid-19.”
In pochi attimi, la città lagunare si ritrova così catapultata da un estremo all’altro, dall’eccesso di fruizione antropica che caratterizza la macchina del divertimento al divieto di accesso prescritto da ordinanze sempre più restrittive. Da capitale mondiale del turismo di massa a zona rossa in un breve, incredulo, battito di ciglia.
Quelli che seguono sono giorni strani, di apprensione, smarrimento, curiosità. Per la prima volta ciò che sembrava acquisito come diritto inalienabile, la libera mobilità, viene negato anche al privilegiato Occidente. Ciò che sembrava impossibile anche solo da immaginare, la sospensione del turismo, diviene realtà fattuale. Tutto in città tace, a parte rondini e pettirossi, il cui canto avanza man mano che la presenza dell’uomo si ritrae dallo spazio urbano. È un silenzio denso di interrogativi, ma povero di risposte, che cala su una città che ha fatto dell’industria turistica il perno fondante della propria economia. Lo ha fatto sicura di poter contare su un business apparentemente inarrestabile, in crescita da decenni di almeno un 7% annuo, che nessuna crisi globale aveva finora potuto stemperare. Un business con tassi di redditività incomparabili, capace di generare rapidamente soldi facili, sicuri, o almeno così sono sempre sembrati.

Spazi urbani svuotati durante la pandemia di Covid-19. Foto: Anna Pruckmayer
Pillole di storia
Sono gli anni Settanta, a seguito dell’alluvione più drammatica della storia veneziana, quando una nuova sensibilità ambientale e l’impeto di una stagione di lotte operaie rendono evidente l’obsolescenza del modello industriale di Porto Marghera, su cui le classi dirigenti del passato avevano puntato. Se Venezia non può più essere città industriale nella competizione globale, quale può diventare il suo destino? La crisi del sistema produttivo viene a coincidere con l’espansione del turismo di massa negli anni del boom economico.
Un richiamo troppo succoso per essere ignorato: il turismo è la scelta più semplice, è già lì, a portata di mano, forte dell’organizzazione capitalistica dell’accoglienza già approntata in Laguna nel corso dell’Ottocento. È da questo momento che l’industria turistica diviene il faro guida dello sviluppo cittadino, in una corsa galoppante che riceverà una nuova accelerazione alle soglie del 2000, con la nascita dei voli low cost, la diffusione dei city breaks e l’esplosione della ricettività extra-alberghiera. Nel frattempo, la popolazione della città d’acqua continua a diminuire, con picchi di 5.000 fuoriusciti all’anno tra gli anni ‘50 e ‘60, per assestarsi poi intorno ai 1.000 dei tempi più recenti. Un vero e proprio esodo degli abitanti, che in massa si trasferiscono verso la terraferma circostante, espulsi dalla rifunzionalizzazione terziaria della città d’acqua.
Qui, i prezzi delle abitazioni sono divenuti insostenibili in rapporto alla loro qualità. Venezia si trasforma perciò in una città di case vuote, seconde case, residenze di lusso. In un secondo momento, in un dormitorio turistico diffuso, fatto di depandances, esercizi ricettivi, locazioni turistiche. Alla fine, dei 175.000 abitanti del dopoguerra ne rimangono oggi circa 52.000. La classe media, operaia e impiegatizia, che non può più abitarvi, ritorna però quotidianamente nella città insulare per lavorare in uffici e botteghe: nel 1964 i pendolari in entrata sono già 16.800, il 33% della popolazione occupabile. Venezia diventa così un paradigma. Non però per l’unicità della sua morfologia né per la sua storia millenaria, ma in quanto primo esperimento italiano di appropriazione di una città storica, tutta intera, e di sua riorganizzazione funzionale al pari di una fabbrica. «Come settore produttivo finalmente integrato a massimo regime nel quadro dello sfruttamento capitalistico del territorio»[1].

Traffico di gondole in una normale giornata turística. Foto: Clara Zanardi
Così come l’Acqua Granda del 1966 aveva squarciato il velo sull’insostenibilità ambientale del polo petrolchimico, l’alluvione del novembre 2019 ha però riportato in primo piano la fragilità ecosistemica della città. Ha dimostrato empiricamente quanto la sua iper-infrastrutturazione ne abbia sconvolto gli equilibri, ovvero quanto sia esposta agli effetti di quello stesso cambiamento climatico che la sua economia quotidianamente alimenta. Pochi mesi dopo, il sistema produttivo dominante, quello turistico, viene scosso dal primo arresto globale della sua storia. Le fondamenta della sussistenza veneziana, e dell’intera regione che vi gravita attorno, si scoprono nuovamente fragili e malferme. Una volta di più, la città lagunare è chiamata a convertire la propria economia. E anche se non si tratta di una apocalisse, ci troviamo tuttavia di certo in un «intervallo. Una pausa di silenzio nel rumore, che può risultare produttiva o essere il preludio di una conferma, se non di un aggravamento, dell’ordine (o del disordine) precedente»[2].
|
Una Venezia all’incontrario
Nel frattempo, bloccato l’accesso ai cosiddetti city users (studenti, turisti, lavoratori pendolari), i pochi abitanti si guardano intorno, animati da sentimenti ambivalenti. Da un lato, dopo decenni di progressiva sottrazione dello spazio pubblico ad opera dell’industria turistica, riscoprono il piacere di fruire indisturbati della città, finalmente libera da grandi “masse” di visitatori, dall’inquinamento penetrante, dai rumori e dall’ingombro delle attività turistiche, dal pericolo del moto ondoso. Dall’altro, a causa delle restrizioni della mobilità, non possono che sfiorare questo piacere, senza poter godere con naturalezza dello spazio lagunare e delle sue potenzialità. Un paradosso non da poco, per cui ci si è ritrovati improvvisamente in uno spazio pubblico liberato, senza però poterne disporre liberamente, con in più il timore che esso svanisca come un sogno troppo breve al termine della quarantena.
Ma accanto al piacere per l’assenza dei turisti, che in primavera rendono normalmente la città invivibile, c’è stato lo sgomento per le calli vuote, le saracinesche abbassate, i balconi chiusi. Venezia, depurata artificialmente dai suoi transitanti, appare infatti pressoché deserta. Ridotta all’osso e forse proprio per questo realistica come non lo è mai stata, costretta a confrontarsi con ciò che di sé è rimasto, con ciò che è divenuta. Nel momento in cui i negozi non necessari vengono chiusi, ci si accorge inoltre di quanto esiguo sia nei fatti il necessario. Di quanto poche siano ancora le botteghe per residenti, gli alimentari, i mercati. Di quanto invece il superfluo, la paccottiglia, le grandi firme, il souvenir, il take away, il bar-enoteca-hostaria-ristorante, siano cresciuti come un ipertrofico bubbone nel tessuto urbano, riempiendone ogni anfratto. Oggi che la pandemia riporta la società signorile di massa ad un consumo minimale, la gran parte della città è inservibile. È una Venezia all’incontrario: progettata nei decenni come destinazione turistica, si trova a esperire la povertà della propria funzione residenziale ridotta ai minimi termini. Perfino i servizi di base, come il trasporto pubblico, sono stati disegnati sull’utenza turistica, al punto da rischiare il default in sua assenza: “il sistema stava in piedi con i soldi del turismo che non torneranno”, dichiara il sindaco.

Usi liberi di uno spazio lagunare insolitamente tranquilo. Foto: Clara Zanardi
Nel vuoto, un’opportunità
Eppure, se è vero che è dalla consapevolezza che maturano le scelte e germoglia la spinta al cambiamento, questo confronto con la dura realtà rappresenta allo stesso tempo un’occasione unica per Venezia. «Il vuoto è un evento formidabile. La stasi è la cosa più vitale che la città abbia visto da parecchi decenni a questa parte. È la visione di una possibilità, di una ripartenza. There is an alternative»[3]. Per la prima volta, infatti, ci si può concentrare sulle esigenze effettive del territorio e sui suoi bisogni primari, senza preoccuparsi di dover prima togliere. Non occorre più diradare la popolazione per ridurre il sovraffollamento, come nell’immediato dopoguerra, né limitare l’accesso ai turisti, con tutte le difficoltà logistiche e legali che ciò comporta. Tornelli e sbarre appaiono ancora più ridicoli, il crocierismo è imploso nel suo stesso orrore, le nuove piste aeroportuali sono cattedrali nel deserto. Anziché togliere, bisogna scegliere: aprire e ampliare gli spiragli che la monocoltura turistica non ha potuto ancora colonizzare, riconquistare spazio, riguadagnando le case, i campi, le calli, le isole, le acque. Come ricorda Paola Somma, infatti, l’uscita dalla pandemia «sarà una vera e propria guerra di classe, il cui esito dipenderà non poco da chi conquisterà lo spazio pubblico»[4]. La vita urbana potrebbe così ripartire dal suo nucleo fondante per ricostituirsi: dai suoi abitanti e da coloro che finora non hanno potuto insediarsi pur desiderandolo, dal suo ineguagliabile territorio, dal suo patrimonio edilizio, dai suoi spazi, dalle sue attività tradizionali. Da un lavoro dignitoso, diverso dalla manovalanza sotto-qualificata e sotto-pagata impiegata nel ricettivo e nella ristorazione, lasciata a casa senza alcuna tutela al minimo accenno di crisi.
Si tratta cioè di rivendicare finalmente il valore d’uso della città e dei suoi luoghi, di contro all’imposizione di un valore di scambio che negli anni li ha trasformati in merci, privatizzati e sottratti alla collettività. Di costruire e mantenere una città per le persone, non per il profitto[5], difendendo il modello di un abitare radicato di lungo periodo, piuttosto che rincorrere un cosmopolitismo fatto di superfici omologate da attraversare e consumare (l’esatto opposto del Belong Anywhere propagandato da Airbnb). Di garantire, infine, quel right to stay put che è condizione indispensabile di ogni appello al diritto alla città e che non si pone più nei termini retrivi dell’appartenenza identitaria, ma di un investimento politico diretto degli abitanti nella gestione del proprio territorio, urbano o non urbano che sia.
Dare corpo al concetto ormai onnipresente di diritto alla città significa infatti recuperarne il senso lefebvriano di “autogestione generalizzata”, che non è riducibile al diritto a un abitare più dignitoso, ad affitti più bassi, ecc, nel quadro della città capitalistica, ma si concretizza piuttosto nella rivendicazione più ampia di «una vita molto diversa nel contesto di una società a sua volta molto diversa, molto più giusta»[6]. Ovvero una società non capitalistica, in cui non siamo chiamati solamente a “partecipare”, in modo più o meno scenografico, ma che chiediamo invece di autogestire. Con tutte le difficoltà, le incognite e le tremende responsabilità che ciò implica.
|
La politica del rimbalzo
Il presente e il futuro appaiono tuttavia ancora molto lontani da un simile scenario, dominati invece da una politica top down che si accanisce ciecamente sugli errori di sempre, con la ritmica testardaggine di un orologio a cucù. Come risulta evidente a Venezia, dove mai come oggi la possibilità di salvare la città dalla decadenza potrebbe uscire dal regno degli slogan retorici e divenire realtà, dal momento che la conversione ad un sistema economico diversificato non è più solo un auspicio, ma un passaggio obbligato.
Invece, nel pieno della crisi virale il sindaco si prestava ad un’imbarazzante pagliacciata in compagnia di Zucchero, sullo sfondo di una piazza San Marco desertificata per l’occasione, lasciandosi andare a un’ode lirica alla filiera turistica. La sua visione del futuro della città? Ripartire dal turismo, dagli spettacoli, dagli eventi, rilanciando Venezia con un grande ciclo di concerti sull’acqua. Un circo, insomma, in cui gli abitanti non sono nemmeno contemplati. Idea ripresa dall’assessore regionale al turismo, che si offre di ospitare «gratuitamente, e con gratitudine, tutti i personaggi famosi che riterranno di venire in questa storica terra». L’oggetto del desiderio dei politici locali, infatti, non è – come non è mai stato – una città vitale, nuovamente abitata e vissuta, ma il testimonial, che riporti una Venezia di cartapesta al centro del palcoscenico mediatico globale. Un pensiero unico che attraversa tutte le correnti politiche, tant’è che un altro candidato sindaco alle locali amministrative, Baretta, si spendeva nel frattempo per garantire forti incentivi all’industria turistica, insieme a deroghe normative e semplificazioni amministrative, sospensione dei tributi, bonus vacanze e finanziamenti a fondo perduto. Infatti, come tristemente notava, «il nostro primo compito è riportare i turisti».
Piuttosto che avviare una riflessione critica doverosa sui limiti, le debolezze e le esternalità negative dell’industria turistica, mai come oggi divenuti evidenti, a tutti i livelli governativi si procede perciò in direzione di una ripresa tale e quale del modello precedente. Peggio, si spinge per una ripartenza accelerata, per una crescita che a tutti i costi faccia recuperare gli incassi perduti, sacrificando procedure burocratiche, normative urbanistiche, limiti di legge, vincoli ambientali. A scapito soprattutto dello spazio pubblico, o di ciò che ne rimane, che in maniera sempre più massiccia dovrà essere sottratto all’uso collettivo per recuperare in estensione spaziale il tempo sottratto agli affari. E così gli stabilimenti balneari si allargano nelle poche spiagge libere rimaste, mentre tavolini di bar e ristoranti occupano gratuitamente ogni centimetro residuo di strade e piazze. Con il rischio che il ritorno sia non semplicemente ad una normalità già insostenibile e patogena, ma ad una normalità iper-accelerata, ancora più indifferente al diritto delle popolazioni all’abitare e alla libera fruizione dello spazio e dei beni collettivi. Non è quindi un caso che il documento di proposte presentato dal sindaco di Venezia per «contrastare l’emergenza e ripartire con un nuovo slancio» si chiami #RimbalzaItalia. La visione è infatti quella di una città che rimbalza, che sbatte contro un ostacolo e torna indietro, rimanendo uguale a se stessa. È l’atto stolido di chi è incapace di trasformarsi e organizzarsi in relazione alla realtà delle cose e ai suoi mutamenti, ma semplicemente viene buttato di qua e di là dagli eventi come una pallina di gomma.
Una città che rimbalza, però, non è quella in cui i suoi abitanti desiderano vivere, perché questa è la città che, se non li ha espulsi finora, li espellerà domani, in favore di un altro tipo di soggetti. Il dramma della turistificazione sta infatti proprio in questo: è una operazione di “tassidermia urbana”[7], che non si limita ad espellere le classi medio-basse dai centri cittadini per sostituirle con il ceto abbiente -come avviene nei classici processi di gentrification-, ma svuota intere città, drenandone risorse umane, ambientali, culturali, economiche. L’esito ultimo non è perciò una città di soli ricchi, ma una città di soli utenti transitori, senza abitanti. Una china lungo cui Venezia si è avviata già da anni, triste monito per ogni altro nucleo urbano del pianeta.
In un ambiente di questo tipo si realizza infatti quella che Bauman definiva tourist syndrome, laddove l’abitare finisce per assumere a sua volta la forma dell’esperienza turistica e «la presunzione di temporaneità si inscrive dentro il modo di essere e comportarsi». Con la conseguenza che si rinuncia a qualsiasi sforzo prolungato verso la creazione di un modus vivendi condiviso, ci si sposta da un luogo all’altro in un “pascolo” ininterrotto, si evita la fatica insita nella costruzione di relazioni stabili e durature con il proprio contesto e con la collettività che lo abita e, infine, si scansa qualsiasi forma di conflitto o lotta sociale[8].
Come rivendicare perciò da un luogo di questo tipo un diritto reale ed effettivo alla città? Quali abitanti sono rimasti a rivendicarlo? Quali soggetti possono organizzarsi per conquistare il diritto a riplasmare ed autogestire il territorio? E quale diritto può infine essere invocato a una città svuotata?
Sono interrogativi cui oggi non è affatto semplice dare una risposta, ma quantomeno ci guidano a invertire l’ordine delle priorità e a sovvertire l’ordine comune del discorso. Non si tratta infatti di come riportare i turisti – unico problema che sembra oggi occupare il dibattito pubblico, ma di come riportare gli abitanti in una città svuotata dal turismo.
In fondo, la chiave della millenaria sopravvivenza di Venezia è stata proprio la capacità di non restare vittima di strutture rigide e di rimodularsi continuamente in base alle sollecitazioni più diverse. Di restringersi e dilatarsi nei secoli. Di trasformarsi, anziché rimbalzare, anticipando le tendenze globali pur nella sua molecolarità insulare. Un compito cui è chiamata anche oggi, nel modo forse più urgente e radicale di sempre, per convertire radicalmente la sua economia e la sua organizzazione politica e non ritrovarsi un’altra volta arida e scabra nel deserto della monocoltura turistica.
_______________
[1] AAVV, Casa, Esodo, Occupazione. Atti del convegno del PCI, Venezia, 18-19 Giugno 1973, Editori Riuniti, Roma 1974.
[2] Lucia Tozzi, Dopo il turismo. Milano, Nottetempo Edizioni, 2020.
[3] Lucia Tozzi, Dopo il turismo. Milano, Nottetempo Edizioni, 2020.
[4] Paola Somma, “Solo la scuola può salvarci dai piazzisti di San Marco”, www.emergenzacultura.org, 05/05/2020
[5] Neil Brenner, Peter Marcuse, Margit Mayer, Cities for people, not for profit: Critical urban theory and the right to the city, Routledge, 2012.
[6] Marcelo Lopes De Souza, «Which right to which city? In defence of political-strategic clarity», Interface, 2.1, 2010, pp. 315-333.
[7] Marco D’Eramo, Il selfie del mondo: indagine sull’età del turismo, Feltrinelli 2017.
[8] Adrian Franklin, «The tourist syndrome: An interview with Zygmunt Bauman», Tourist studies 3.2, 2003, pp. 205-217.
|
Nota sull’autrice
Clara Zanardi. Antropologa urbana e attivista per una descrescita turistica. Laureata in filosofia, ha conseguito un dottorato in Storia delle società e delle istituzioni presso l’Università di Trieste con una ricerca sull’esodo dei veneziani dalla città insulare. Vive e lavora a Venezia, dove si occupa di turistificazione, diseguaglianze urbane, processi di displacement. E’ autrice di Sul filo della presenza. Ernesto De Martino fra filosofia e antropologia (Unicopli, 2011).
| Para citar este artículo: Clara Zanardi. Se il diritto è a una città svuotata. Venezia nel deserto della monocoltura turistica. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 13 Derecho a la ciudad. A Coruña: Crítica Urbana, julio 2020. |